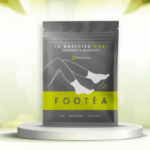La poltiglia bordolese rappresenta uno dei preparati più diffusi in ambito agricolo e hobbistico per la prevenzione e la cura di malattie fungine su numerose colture. Tuttavia, spesso viene confusa con altri prodotti simili a base di rame, come l’ossicloruro di rame, che hanno caratteristiche, campi d’impiego e precise modalità d’uso differenti. Comprendere le peculiarità della poltiglia bordolese e imparare a distinguere correttamente tra i vari prodotti è fondamentale per evitare errori di trattamento, danni alle piante e rischi ambientali.
Caratteristiche della poltiglia bordolese e suo utilizzo
Questo composto nasce dalla miscela di solfato di rame e calce idrata, sciolti in acqua, e si presenta con una colorazione azzurrognola data proprio dal rame. Introdotta già nel XIX secolo, la poltiglia bordolese è ancora oggi l’antifungino di riferimento sia per chi coltiva professionalmente che per chi gestisce un orto domestico o un piccolo frutteto. Si applica sulle foglie e sui rami circa alla fine della stagione vegetativa, durante le fasi di maggiore umidità o dopo la potatura, formando una barriera protettiva che, pur rimanendo in superficie e non penetrando nei tessuti vegetali, inibisce la germinazione delle spore patogene grazie al rilascio degli ioni rameici. L’efficacia si esplica contro peronospora, ticchiolatura, antracnosi, monilia, corineo e diverse batteriosi, fornendo così una copertura ad ampio spettro per numerose piante orticole e fruttifere.Solfato di rame .
La poltiglia bordolese si distingue per la sua efficacia preventiva: deve essere usata preferibilmente prima che si manifestino i sintomi della malattia. L’applicazione avviene, generalmente, durante il periodo autunno-invernale per la disinfezione delle piante a riposo vegetativo e nelle fasi precoci della ripresa vegetativa. Un aspetto rilevante è il fatto che, una volta asciutta, la poltiglia possiede buona persistenza sulle superfici trattate, soprattutto grazie alla presenza della calce, che funziona da “adesivante” e aiuta a contrastare la pioggia.
Va ricordato però che l’uso della poltiglia non può essere indiscriminato, ma deve seguire le indicazioni contenute in etichetta per evitare fenomeni di fitotossicità, particolare durante la fioritura, dove può danneggiare gli organi florali o risultare tossica per il polline, e nei periodi più caldi, quando la pianta è in vegetazione attiva .
Non solo poltiglia bordolese: i prodotti simili
La poltiglia bordolese appartiene alla vasta famiglia dei formulati a base di rame, elemento centrale nella protezione delle colture dagli agenti patogeni fungini. Tuttavia, esistono altri prodotti sul mercato che possono essere facilmente confusi con essa:
- Ossicloruro di rame: si presenta in forma di polvere bagnabile o sospensione in microgranuli; è un altro fungicida rameico molto usato come alternativa alla bordolese per la sua maggiore praticità di uso, persistenza e minore fitotossicità rispetto ad altri sali di rame. Ha un colore tendenzialmente verde-azzurro ed è più adatto per interventi preventivi anche nelle fasi vegetative, sempre seguendo le corrette dosi per evitare effetti tossici sulle colture.
- Idrossido di rame: caratterizzato da una maggiore solubilità, viene prevalentemente utilizzato in trattamenti rapidi contro infezioni primaverili, ma può essere più fitotossico e di minor durata se confrontato con la poltiglia bordolese.
- Solfato di rame tribasico: fungicida a base di rame con elevata efficacia e buona selettività, spesso preferito nelle colture di frutta dove si desidera ridurre la quantità complessiva di rame distribuito per ciclo colturale.
Un errore comune è quello di considerare questi formulati analoghi e intercambiabili; in realtà, ogni tipologia presenta proprietà differenti (persistenza, velocità d’azione, rischio di fitotossicità) e pertanto la scelta va valutata in funzione della fase fenologica della pianta e del patogeno da combattere .
Consigli pratici per un uso corretto
L’impiego della poltiglia bordolese richiede alcune accortezze tecniche fondamentali per ottenere una buona riuscita del trattamento e preservare la salute delle piante e dell’ambiente:
- Preparare la soluzione fresca: la miscelazione del solfato di rame con la calce va eseguita preferibilmente subito prima dell’uso, mediando accuratamente le quantità per ottenere una reazione chimica bilanciata e una sospensione omogenea.
- Non trattare durante la fioritura: nei periodi in cui le piante sono in piena fioritura o in fase di allegagione, è meglio sospendere i trattamenti per non rischiare di compromettere la vitalità del polline o provocare ustioni agli organi sensibili .
- Rispettare dosi e intervalli: un eccesso di rame può accumularsi nel terreno, impoverendo la sua microfauna utile; quindi si consiglia di alternare, quando possibile, la poltiglia ad altri mezzi di difesa, e limitare le dosi secondo le prescrizioni di legge e di etichetta.
- Prediligere interventi mirati: puntare su trattamenti preventivi in condizioni di rischio elevato per la presenza di pioggia e umidità, limitando i trattamenti successivi all’insorgenza di un’infezione.
- Proteggere le specie sensibili: alcune piante, come pesco e albicocco, possono essere particolarmente suscettibili ai trattamenti, soprattutto in fase attiva; in questi casi valutare alternative come il polisolfuro di calcio o fungicidi meno aggressivi.
L’applicazione in inverno è consigliata soprattutto su piante in riposo vegetativo, dopo la caduta delle foglie e prima della comparsa dei primi boccioli, per sanificare ferite accidentali dopo la potatura e prevenire la comparsa di cancri rameali e altre patologie fungine. In estate e nei momenti di forte vegetazione, invece, è preferibile sospendere l’uso dei rameici o ricorrere a formulati meno aggressivi.
Conclusioni e avvertenze sugli errori più comuni
Risulta quindi evidente che la poltiglia bordolese, se ben dosata e applicata secondo le precise necessità colturali, mantiene ancora oggi una posizione di rilievo tra i prodotti antifungini adatti sia per l’agricoltura tradizionale che per quella biologica. Tuttavia, vanno evitate alcune confusioni che risultano ancora diffuse:
- Non confondere la poltiglia bordolese con ossicloruro o solfato di rame puro: ogni prodotto ha tempi e modalità di impiego diversi, nonché rischi di fitotossicità specifici.
- Attenzione alle (formulazioni commerciali): leggendo attentamente le etichette è possibile distinguere chiaramente la tipologia di sale di rame contenuto e la percentuale effettiva di principio attivo.
- Non eccedere nell’uso per salvaguardare ambiente e suolo: il rame è un metallo pesante, il cui eccesso può provocare danni irreversibili agli organismi utili e alterare le caratteristiche del terreno a lungo termine.
Un uso consapevole, supportato dalla conoscenza delle caratteristiche chimico-fisiche dei formulati e dalla scelta del momento ottimale per effettuare i trattamenti, rappresenta la migliore strategia a tutela sia delle coltivazioni che della salute ambientale. Solo così si evita di ricorrere impropriamente alla poltiglia bordolese quando non serve, o di commettere errori confondendola con altri prodotti simili ma non identici nel loro meccanismo di azione e nel loro impatto sulle colture.